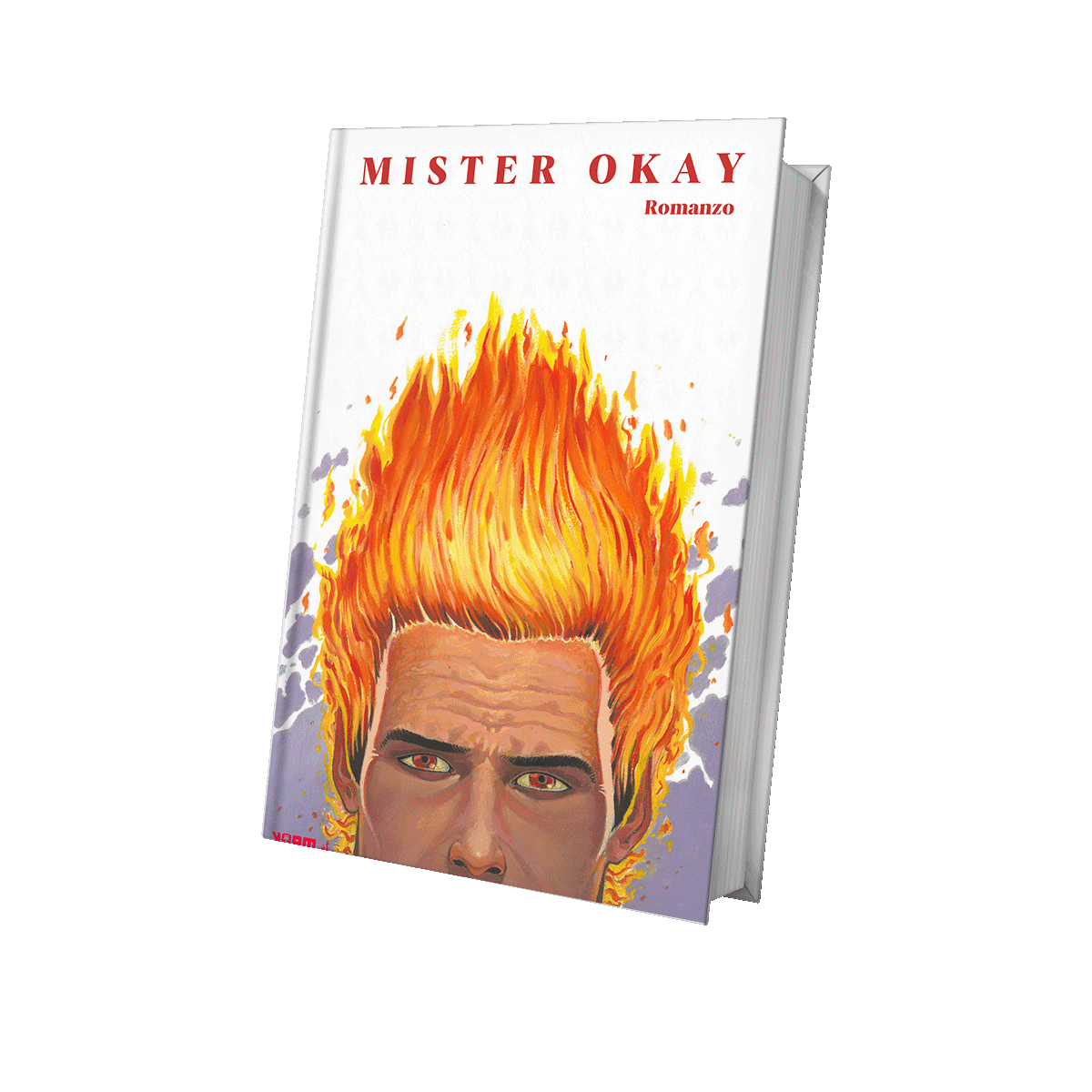JOEY THE RIPPER
La notte era calata benigna sulla grande città ormai già da parecchie ore. L’oscurità si sposava alle brume che risalivano puntuali dalle acque salmastre del Tamigi, formando una coltre quasi impenetrabile alla vista e quasi solida al tatto. Come un sesquipedale pudding di segale rovesciato su quella che nelle ore diurne era la metropoli più corrusca e febbrile dell’intero globo.
Quel monoblocco color pece ovattava ogni rumore, tutto si faceva sussurro, schiocco soffocato. L’unica cosa che udiva, attraverso il feltro grezzo del suo copricapo, era uno strascichio regolare, contrappuntato da un breve tonfo. Era la cadenza del suo cammino, quando puntava il piede destro a mo’ di leva e si trascinava poi dietro quello sinistro per rimetterli in asse e ricominciare da capo, passin passetto. Una marcia penosa, ma non eccessivamente prolungata, considerando la distanza che intercorreva tra il Royal London Hospital e il cuore dell’East End, dove era diretto, come ogni tanto faceva da qualche mese a quella parte.
La notte fonda non lo opprimeva, anzi. Era il suo elemento. Come per i gatti in amore o i pipistrelli in cerca di prede. Da sempre era abituato a spostarsi avvolto dal buio. Quanto più la notte era illune e il firmamento coperto e meglio era. Solo così poteva portare in giro le sue deformità senza destare troppa attenzione, pur premurandosi, nonostante tutto, di procedere rasentando i muri e acquattandosi appena possibile dentro le riseghe presenti lungo il percorso, camuffato sotto vari strati di stoffa affinché non un solo dettaglio del suo corpo affiorasse alla vista.
Sgattaiolare fuori dal cortile dell’ospedale non era stato difficile neanche stavolta, malgrado la grave zoppia e la sua difficoltà nei movimenti. Se ne era rimasto tranquillo dentro l’alloggio che avevano ricavato per lui nell’ala addossata ai magazzini, a luce spenta, senza produrre il minimo rumore perché tutti lo credessero già sprofondato nel sonno. Attese che il viavai del corpo infermieristico scemasse, finché non fu certo che fosse giunto il fine-turno, sbirciando sul quadrante dell’orologio da taschino regalo di chissà quale lord o madamina in visita di cortesia, colpito da un pallido riverbero di luce che l’illuminazione a gas gettava dall’esterno attraverso la finestrella. Fu allora che si spinse fuori dalla stanza in cui era relegato, strisciò contro la parete bianca del corridoio sino all’uscita sul retro, che dava sul cortiletto e, da lì, sull’intrico di strade che formavano Whitechappel, attraverso un cancelletto piuttosto facile da forzare.
Due parti di Londra erano ancora attive a quell’ora, agli antipodi l’una dall’altra: i ricchi festini nelle case private del West End e le bisbocce economiche all’estremità orientale della città, dentro bettole da pochi pence, riempite ogni santa notte dai relitti di quella società ultra-progressista, che vedeva macchinari a vapore incentivare di mille volte la produzione industriale e pascere i ventri molli della borghesia imprenditoriale e, per altro verso, migliaia di operai e sottoproletari languire ai bordi delle strade, dentro topaie maleodoranti, finiti i turni giornalieri a spaccarsi la schiena in fabbrica o al porto per quindici ore filate, in fetide bettole gonfi di gin, assai meno costoso del tè che irrorava le garrule gole delle signore dabbene, riunite nel salotto buono alle cinque spaccate per sorbire decotti di foglioline provenienti via mare dai demani appartenenti alla Compagnia delle Indie.
A saturare gli scrausi pub di Whitechappel a quell’ora c’era la peggiore teppaglia all’ombra della corona britannica: puttane sifilitiche, dipsomani senza contegno, grassatori di strada, marioli, forme di vita afflitte da malattie in altri quartieri debellate da almeno mezzo secolo, storpi, mongoloidi, corpi resi monchi o rattrappiti da guerre consumate sull’altra faccia della Terra.
Benché Joey si sentisse più prossimo a costoro che a quella rassegna di signori titolati impomatati e rileccati con le graziosi consorti al seguito, che non c’era giorno non mettessero il naso nei suoi appartamenti pur di leggere l’indomani i propri ridondanti estremi anagrafici sulle prime pagine nazionali, quali consolanti benefattori di un povero infelice, ebbene, per quanto si sentisse più affratellato a questi che non a quelli, gli stigmi che costui recava sul proprio fisico ulcerato erano di un tale abominio da fare apparire quella masnada di miserabili come dei privilegiati al suo confronto.
Per giunta, se quei disperati erano stati ridotti in quelle compassionevoli condizioni da un’ingiustizia perpetrata dall’uomo sull’uomo, chi aveva deciso di condannare Joey a quel gramo destino era stata un’entità superiore ben più ineluttabile delle storture di un apparato sociale in rapida crescita: quella stessa natura della quale la temperie positivista di quegli anni non si stancava di indicare i retti e benevoli principi.
Si infilò in un postaccio che faceva angolo. Nessuno si accorse di lui, malgrado il pesante pastrano che indossava e il berretto sformato calzato sulla grossa testa con un velo di iuta che gli faceva il giro della nuca. Ce n’erano di tipi strani lì dentro, uno più uno meno non faceva una gran differenza.
Pur muovendosi guardingo, cercò di mischiarsi a quella piccola assurda folla. Non cercava lo spasso né libagioni a buon prezzo. Cercava una persona in particolare. Una ragazza che in un’uscita precedente aveva adocchiato sul marciapiede opposto. Aveva portato quell’immagine con sé al suo rientro in ospedale, lasciando che gli gonfiasse il petto in quei lunghi giorni d’attesa, prima di poter tornare sulle sue tracce.
Era già da una buona mezzora che se ne stava appoggiato al muro, all’incrocio delle pareti, perlustrando invano quell’accozzaglia di teste ciondolanti, quando finalmente la rivide, mezza dentro e mezza fuori dall’entrata. Il povero cuore di Joey perse un battito.
C’era chi la chiamava Ginger, per via del colore rossiccio dei bei capelli, tenuti a bada da un cappello a veletta calcato sull’ampia fronte, chi Black Mary per la sua preferenza per gli abiti scuri, chi ancora Fair Emma per la sua avvenenza, che neppure la consuetudine all’alcol e la vita di strada erano riusciti a intaccare più di tanto. Il suo nome completo era Mary Jane Kelly, e la sua esistenza non era sempre stata quella di una battona attaccata alla bottiglia. Aveva avuto origini oneste, si era sposata con un uomo timorato di Dio e ne era rimasta presto vedova, aveva visto il bel mondo in qualità di amante di un generoso dandy. Alla fine il fato le aveva giocato un brutto scherzo, spedendola tra quelle bolge fuori mano.
Joey le andò incontro, faticosamente. Quando Mary si trovò all’improvviso al cospetto di un figuro tanto bizzarro sobbalzò. Stava indietreggiando forse per svignarsela, quando le arrestò il passo un ventaglio di sterline di grosso taglio, scippate dal paltò incustodito del suo medico curante, il Dottor Treves, che Joey le fece frusciare sotto il naso. Quella sequenza di profili della Regina Vittoria ebbe il potere di trasmetterle una gioia istantanea. Gli strappò di mano una banconota e la porse al barista guercio, che da dietro il bancone strabuzzò l’occhio sano: «Dammene una di quello buono» comandò.
Anche l’approccio di Mary si era addolcito, mentre sgarganellava allegramente il liquido viscoso dal colore torbido e, tra un sorso e l’altro, si rivolgeva al munifico interlocutore, che rispondeva ai suoi modi ciarlieri con strani versi, difficili da comprendere: «Siete straniero, bello mio? Da che strana terra siete sbarcato? Là da voi si vestono tutti così? Dovete essere arabo, nevvero? Come quelle vostre donne tutte infagottate di cui parlano i reduci delle guerre afgane. Mai stata con un arabo. Potrebbe anche essere divertente…».
Quando Mary alzava il gomito attaccava a cantare. Aveva una bella voce del resto, che sfidava l’umida notte londinese, rimbombando contro i muri incrostati delle casupole disseminate intorno a loro: «And what will those yeomen do, said the shan van vocht. What will the yeomen do, but throw off the red and blue. And swear they’ll all be true, said the shan van vocht» non faceva che ripetere, come un grammofono inceppato, sottobraccio con l’ignoto marpione, tentando di sorreggersi a vicenda, mentre prendevano la via verso casa della ragazza.
«La conoscete? È una canzone irlandese, proprio come me. Sapete da dove vengo io?» chiese con la lingua ormai felpata a Joey, che nel frattempo non aveva mostrato grandi doti da intrattenitore, «Dalla cara, dolce cittadina di Limerick».
Quell’indicazione toponomastica, mai prima orecchiata, seppe catturare la sua attenzione per qualche secondo. Da buon lettore, amante delle arguzie tipiche della letteratura anglosassone che maggiormente consultava, a Joey balzò immediato nella mente un promettente gioco di parole con il proprio cognome, storpiando Limerick in Lee Merrick, “Rifugio Merrick”, quello che gli sarebbe piaciuto costituire d’ora in poi per la graziosa accompagnatrice.
«È una ferita di guerra quella che vi portate appresso?» gli chiese lei, alludendo a quella sua andatura a chiusura di compasso, mentre già si arrampicavano su per la scala che conduceva alle case di ringhiera dell’asfittico cortiletto vicino a Dorset Street, tra le quali figurava la stanzetta presa a fitto da Mary Jane. Neanche a quella domanda diede risposta, come se fosse troppo timido o troppo assorto nei suoi pensieri. “Starà provando a risvegliare mentalmente il pisciolo”, ipotizzò Mary tra sé e sé.
La serratura non funzionava. Per entrarci bisognava inoltrare la mano attraverso un vetro rotto e far scattare la maniglia dall’interno. La stanza si riduceva a un letto a una piazza e mezza con un pagliericcio in buono stato e lenzuola fresche di bucato, un caminetto spento e una modesta toeletta spinta in un angolo.
Era giunto il momento di badare agli affari. «Allora, cocchino bello? Che ne pensate di farmi vedere che si nasconde sotto tutte ’ste gramaglie?» buttò lì Mary, mentre già si slacciava il corsetto e sfilava i piedi candidi e paffuti dai pesanti scarponcini.
Joey non se lo fece ripetere due volte. Cavò via il cappuccio e si liberò del logoro mantello a ruota e di tutto il goffo abbigliamento che ci stava sotto.
Da quel baccello di stracci esorbitò un corpo che sembrava uscito dai più allucinati incubi di un beone in delirium tremens. Il cranio aveva la forma e i bitorzoli di un enorme cavolfiore, il naso non era che uno sgorbio di carne spiaccicato verso il lato destro della faccia, mentre dalla fronte sporgevano tondi tumori grandi come altrettante cucurbitacee. La bocca era una smorfia orripilante che su un lato scopriva una serie di denti guasti conficcati in una gengiva dal colore violaceo e dall’altra prolassava in una specie di becco floscio e tumido. Il busto contorto era sepolto sotto una patina di micosi verdastra il cui odore rancido poteva giusto venir coperto dalla perenne puzza di muffa che contraddistingueva il locale insalubre in cui si trovavano. Il braccio destro terminava in una mano caricaturale, che dava l’impressione di essere stata composta con una manciata di salsicce di carne di porco tenute a bollire troppo a lungo, come nella fantasia di un Arcimboldo particolarmente perverso. In egual modo, gli arti inferiori apparivano come sproporzionati simulacri di un paio di gambe, ricoperti di fibromi, sacche purulente e pendule masse tumorali.
A quella vista Mary emise un tale urlo che i vetri ancora interi della finestra erano lì lì per scoppiare per le vibrazioni. Joey sembrava preparato a una reazione del genere. Un bisturi, sicuramente sottratto a qualche sala autoptica integra al regio nosocomio in cui dimorava, gli scintillò tra le dita, stretto dalla sola mano capace di una presa salda. Il braccio sinistro bianco, tonico, vigoroso era l’unica parte di quel disgraziato corpo a essere perfettamente formata, insieme al pene, ben fatto, di ragguardevole misura, rorido e in quel momento ritto come il chiodo di un elmo prussiano.
Cercava uno scampolo d’amore, come chiunque altro, ma quello che aveva trovato al posto suo, una volta ancora, era il raccapriccio che si riserva a una creatura infernale.
«Io sono un essere umano! Io… sono… un uomo!» le urlò a sua volta, benché le sue parole risultassero più simili a un latrato che a suoni articolati.
Fu allora che Mary Kelly, vincendo il primo disgusto, riconobbe in lui quell’“Uomo Elefante” che un impresario dai pochi scrupoli aveva portato per piazze e teatrino di infimo rango sino a subito prima che l’esibizione di fenomeni da baraccone fosse bandita in tutto il regno, e che attualmente veniva esposto davanti a un pubblico di camici bianchi e cattedratici presso la vicina struttura ospedaliera, suscitando un grande clamore di stampa.
«Ma voi… voi siete Joseph Merrick» balbettò, ricordandosi quel nome appreso da qualche fogliaccio svolazzante per la via.
«Tu chiamami Joey, come faceva mamma» si sforzò di proferire l’altro, tentando di rendere quanto più perspicui quei suoni incoerenti che le sue grottesche labbra riuscivano a esalare.
Mary neanche provò a celare la repulsione verso quella semovente massa informe che aveva di fronte: «Ve ne prego, uscite di qua» singhiozzò.
Sulla maschera che Joey aveva in luogo della faccia, imperturbabile quanto una palla di creta male abbozzata, per un attimo parvero affiorare i segni del risentimento: «Avresti potuto cedere con le buone. Prenderò quel che voglio con modi più decisi…» cercò di dirle, mentre si faceva sotto brandendo l’affilato coltello chirurgico.
Le fu sopra, lei sdraiata di schianto a schiena sotto sul materasso, nella brutale parodia di un congresso amoroso. L’abnorme manona pigiata contro la sua bocca appetitosa, a soffocarne gli strazianti lamenti. L’oscena figura stesa su di lei a impedirle anche la minima ribellione.
Cominciò a infierire sulla parte alta: gola, massiccio facciale, orecchie. Scese al torso, quindi giù da basso, a frugare finalmente dentro il succoso, accogliente tempio del femminino, donde la vita esce e il desiderio entra e si dilata. Ci si sbizzarrì. Dopo aver raggiunto un rapido consenso corporale, non pago, vi si attardò ancora a lama in pugno. L’uovo pasquale conteneva una sorpresa: Mary era incinta di tre mesi. Joey strappò via il figlio dello scaricatore di porto che in quel grembo lo aveva sbrigativamente depositato, non più grosso del pomello di una porta. Osservò quel roseo fagiolone dibattersi per un po’ debolmente, sinché non si decise a spappolarlo dentro il palmo sovradimensionato. Infiocchettò l’intera operazione straziando quelle floride gambe tornite.
Quando ebbe terminato con lei, quello che abbandonò sul letto al suo triste destino di rilevamenti di polizia e tumulazione in una fossa comune era un fantoccio sanguinolento ridotto a sua immagine e somiglianza. «Ora chi è il mostro? Chi è il mostro?» bofonchiava.
Il naso era disassato rispetto al setto, spostato verso destra, proprio come quello di Joey. La bocca era scivolata verso il basso, slabbrata sino ad assumere la forma di un broncio parossistico. Gli occhi erano stati estirpati e posizionati ai lati della porzione di fronte asportata, come un paio di ciliegine in cima a una torta. A incorniciare quella maschera rossa era rimasta, intatta, la fulva aureola della sua chioma vaporosa. La gola era stata recisa tanto profondamente che poco ci era mancato che la decollasse. Le orecchie tagliate via. Al posto dei seni amputati due cerchi di carne viva. Il braccio sinistro che rimaneva ancora attaccato alla spalla giusto per qualche sottile filamento tissutale. La mano destra tranciata e ficcata quasi per intero dentro lo squarcio in mezzo alle gambe. Queste ultime poi risultavano scarnificate sino all’osso, come i resti di due fusi di pollo gettati ai cani. Anche il fegato e il cuore erano stati estratti con violenza e accomodati uno sul ventre divelto, l’altro sul comò.
Joey finì di stendere le budella della ragazza da un chiodo all’altro, dopo aver tolto i quadri che vi erano appesi, con l’accuratezza di un vetrinista intento ad allestire i festoni natalizi, prima di lasciare la stanzetta.
Di lì a pochi mesi Joseph Merrick sarebbe spirato nel proprio letto, provando a dormire coricato come usano i più, soffocato dal peso del suo stesso cranio. I delitti di Jack lo squartatore, dopo lo scempio della Kelly, si interruppero. Nessuno avrebbe mai notato la curiosa coincidenza.
tutti i diritti sono riservati