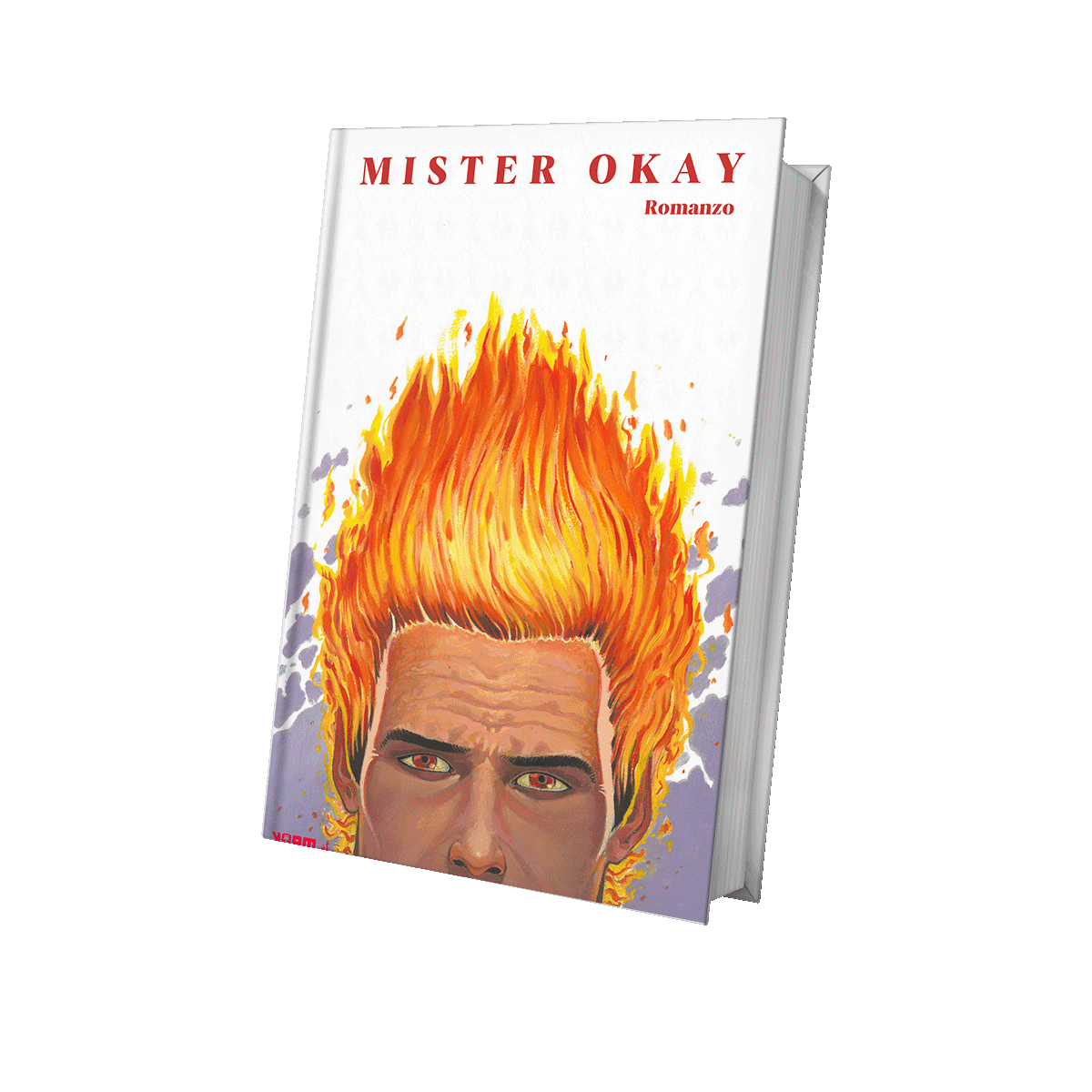Il giallo è il genere che tira maggiormente sul mercato editoriale italiano, e non solo, da qualche decennio.
Che questo sia un bene è tutto da vedere (o da… investigare, sarebbe forse meglio dire).
Già il fatto che oggigiorno la narrativa sia perlopiù composta da generi, mentre un tempo c’era la Letteratura, senza declinazioni subspecifiche, e, a margine, c’era poi la letteratura di consumo, con le diverse tematiche, è significativo; ma questo è un altro discorso.
Possiamo però dire che in tutti gli altri generi troviamo esempi che travalicano le restrizioni di appartenenza dettate da critica e linee editoriali, per entrare di diritto nel più ossigenato territorio della narrativa tout court: Il popolo dell’autunno di Bradbury va ben al di là del romanzo horror, con quell’afflato pomposo ed entusiastico, comune a Melville come a Whitman, che ne sorregge l’intero svolgimento, i thriller di Thomas Harris sanno elevarsi a cupe riflessioni sull’affascinante natura del male, la fantascienza di Philip K. Dick o di Burroughs è innanzitutto uno spaccato socio-politico.
Un giallo, per essere tale, non ha mai questa capacità di smarginare, di affrancarsi dal proprio genere. Un giallo resta comunque un giallo. Con buona pace di quegli autori, come Carlotto o Carofiglio, che amerebbero passare per intellettuali impegnati e, ogni volta che gli è data la possibilità, ci tengono a ribadire di essersi prestati a un genere di letteratura popolare come questo giusto per attrarre un vasto pubblico cui mostrare, servendosi degli stilemi giallistici classici, tematiche sociali ben più vaste e meritorie, il giallo resta comunque quel giochetto fine a se stesso in cui qualcuno viene ammazzato e si deve scoprire il colpevole. Rivelatane l’identità la storia cessa. Potrai anche cercare di infarcirne le pagine di citazioni dotte, psicologismi, riferimenti a scandali e malversazioni che infestano il panorama nazionale, ma il lettore resterà inchiodato al libro, capitolo dopo capitolo, unicamente per la volontà di venire a sapere chi sia l’assassino. Una volta che ne viene informato la funzione della novella cessa automaticamente. Niente al di fuori di quello ha un peso.
Il giallo è autoconclusivo. Ha la principale funzione di tenere la mente del lettore avvinghiata per qualche ora, magari da un capo-tratta all’altro, contro le noie di spossanti viaggi in treno. Non per nulla la sua rivendita d’elezione era ed è l’edicola delle stazioni. Il giallo, nel migliore dei casi, è un simpatico passatempo, nel peggiore, un’uggiosa perdita di tempo. Come si può notare, rischia comunque di essere sempre un riempitivo di quel tempo che per molti, contro la lezione comune, è troppo e difficile da far trascorrere.
Per quanto l’Adelphi voglia darci a bere che i libri di Simenon assurgano alle più alte vette letterarie, per quanto Camilleri sia da anni insignito dell’altisonante titolo di “Maestro”, una volta che Maigret o Montalbano scoprono l’assassino il libro finisce lì, e il percorso che porta dal punto A in cui si scopre il cadavere al punto B in cui si scopre il reo (spesso confesso) è una linea retta che il lettore segue, come si attraversa un tunnel, senza interessarsi più di tanto alle figure di contorno che il giallista colloca ai lati della storia nel tentativo di godere di maggior credito artistico. Quella del giallo è una struttura fortissima, una struttura-gabbia potremmo dire, dalla quale è praticamente impossibile volare pindaricamente altrove.
Perché i prodotti letterari, e quindi teatrali, cinematografici, televisivi, che vertano su indagini intorno a un caso da dirimere, che canonicamente è un caso di omicidio, sino alla risoluzione finale, con la scoperta di colpevole e movente, prendano nome di gialli è cosa nota: in Italia erano di questo il colore le copertine della collana Mondadori specializzata in tali contenuti, il cui lancio avvenne sul finire degli anni ’20 del secolo scorso.
Ma da cosa nasce il genere? In altre parole, qual è l’antesignano di tutti i gialli a venire?
“I Greci hanno già detto tutto” affermava Bertrand Russell nell’introduzione ala sua Storia della filosofia occidentale. Un enunciato che vale anche in quest’occasione. Per rintracciare il primo giallo della storia si deve infatti rimestare nella tragedia antica: l’Edipo re di Sofocle è la prima indagine della storia della letteratura in cui il protagonista deve trovare il colpevole di un delitto. Il colpo di genio di questo classico teatrale, che lo rende il primo e forse il migliore esempio in assoluto, e in quanto tale irripetibile, è che l’investigatore è anche l’assassino. La storia è nota: Edipo, neoeletto re di Tebe, sa che l’unica maniera per debellare l’epidemia che falcidia i suoi sudditi è scoprire chi sia stato a uccidere il suo predecessore Laio, e, una volta scovatolo, eliminarlo per cancellare l’empietà. Edipo è nuovo di Tebe, conosce poco della città e dei suoi recenti trascorsi. Partono capziose indagini, attraverso le quali Edipo giunge a ricostruire l’accaduto, sino a dedurre che l’assassino di Laio è proprio lui (tacendo qui le restanti implicazioni pre-freudiane).
Da lì in poi, la strada era segnata. Una strada che rassomiglia alla retta della geometria euclidea, che porta dal punto A (nella fattispecie, l’emergenza di un delitto) al punto B (la scoperta del colpevole). Il meccanismo è sempre quello, da migliaia di anni, per quanto ci si sforzi di buttarci dentro cenni storici, socio-politici, particolari raccapriccianti oppure sofisticati da lì non si scappa.
Per questo il giallo, che da fuori pare tanto intricato, almeno per quanto riguarda lo scheletro narrativo, da scrivere è invece il genere più semplice di tutti: si pensa all’omicida e al suo atto e si procede mentalmente a ritroso fino a completare la storia, che resta ormai solo più in attesa di essere rivoltata come un calzino.
Alla suindicata trama classica, detta Whodunit, in cui consiste la maggior parte della produzione giallistica, da I delitti della Rue Morgue di E.A.Poe al gioco del Cluedo, si possono anche affiancare relative varianti, come il cosiddetto howcatchem, in cui il fruitore conosce sin dall’inizio l’identità dell’assassino e non gli resta quindi che accomodarsi e vedere come faccia l’investigatore di turno a raggiungere le sue stesse conclusioni (ne sono il miglior esempio i telefilm del Tenente Colombo).
Ma perché dunque i gialli, nonostante composti da una narrazione tanto ritrita, non accennano a stancare i lettori, ma, anzi, sembrano accalappiarne continuamente di nuovi?
Sciascia, che in fondo è un giallista, risponde a questa domanda asserendo che il giallo è rassicurante, giacché, al contrario della vita vera, alla sua conclusione la soluzione del caso è assicurata.
Questo è il pregio, ma anche il peggior difetto del genere giallo, il cui schema fisso è talmente rigido e immutabile che il fruitore tende a seguire la pista principale (l’indagine), rintuzzato pagina dopo pagina a conoscere il nome dell’omicida e le esatte modalità dell’omicidio, senza che alcun altro aspetto che l’autore si fregi di inserire possa davvero interessarlo. Tant’è vero che, quando veramente gli argomenti trattati e la profondità con cui vengono trattati surclassano la struttura-modello non ci si accorge neanche più che quello tecnicamente appartiene al genere: Delitto e castigo ne è un buon esempio. Lo stesso vale per la graphic-novel Watchmen, in cui quel geniaccio di Alan Moore riesce a esaltare ben più le tormentate psicologie dei supereroi da lui creati e il milieu ucronico attorno a loro, piuttosto che l’identità di chi li stia ammazzando uno per uno, a cui, nel finale, il lettore viene condotto senza quasi accorgersene, impegnato com’è a focalizzare ben altri aspetti della vicenda.
L’eccellenza delle decostruzioni giallistiche rimane comunque da conferire a Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, in cui Gadda usa a pretesto l’impianto tipico del giallo, con una morta ammazzata nei primi capitoli e le conseguenti indagini svolte dal commissario Francesco Ingravallo per determinare l’autore del crimine. Tuttavia, per distogliersi in extremis dagli obblighi del genere, l’Ingegnere elimina il capitolo finale, quello risolutivo, quello in cui di norma si viene informati circa l’artefice del delitto-motore dell’intera storia. Quando gli chiesero perché non rivelasse nel suo romanzo il nome dell’assassino (come avrebbe invece poi fatto Pietro Germi, nel film a quel libro liberamente ispirato), Gadda rispose: «E che importa? L’importante è che lo sapesse don Ciccio Ingravallo».
In una tale ripetitività gran parte del coinvolgimento per il lettore è deputato alla figura dell’investigatore. Ebbene, ce n’è uno in particolare la cui creazione è di una tale levatura da avergli fatto superare gli angusti limiti del genere di appartenenza per relegarlo a icona letteraria alla pari di Emma Bovary o David Copperfield, se non più. Si sta ovviamente parlando del magnifico personaggio concepito da Arthur C. Doyle, e da questi chiamato, con un’ingegnosa operazione di marketing sin dal nome, Sherlock Holmes.
A parte le origini archeologiche del giallo, cui prima accennavamo, la sua moderna inaugurazione viene generalmente fatta risalire a I delitti della Rue Morgue di Edgar Allan Poe, in cui a svolgere le indagini è l’acutissimo Auguste Dupin.
Spesso nelle arti accade che non sia l’intuizione originale a raggiungere da subito la migliore resa: occorre che un secondo punto di vista la adotti per percorrerne tutte le sue intrinseche potenzialità. È quel che succede al cubismo di Braque, quando viene rimaneggiato da Picasso, per esempio. Anche per quanto riguarda il famoso flusso di coscienza, che col capitolo finale dell’Ulysses cambierà per sempre l’approccio psicologico ai personaggi letterari, Joyce confessò di non averci pensato lui per primo, ma di averlo visto applicato in un libro da edicola di stazione, consultato casualmente quella volta che gli era capitato di perdere la coincidenza di un treno. Ci volle però il genio joyciano per rendere quella rudimentale invenzione pura storia della letteratura.
Così avviene anche per Holmes, rispetto al capostipite Dupin: Doyle riesce a portare le caratteristiche già in nuce nell’investigatore di Poe a livelli mitopoietici, rendendo così la propria creatura il vero antesignano di tutti gli investigatori che si avvicenderanno dopo di lui (da Poirot a Maigret, sino alla signora Fletcher).
Doyle sosteneva di essersi ispirato per la costruzione di Holmes a un formidabile diagnosta sotto cui aveva svolto per qualche tempo i suoi servizi clinici. Come per il modello reale, la sofisticatissima mente di Sherlock Holmes riesce a scovare indizi laddove l’uomo comune, testimoniato dal fido resocontista John Watson, sorvolerebbe alla leggera, concatenando, a partire da questo, una serie di ragionamenti fulminei che risalgono rapidamente dall’effetto alla causa, o alle concause. Il metodo adoperato da Holmes, a detta del suo stesso autore, è la deduzione, sebbene Umberto Eco (che su Holmes si basò in maniera lampante, sin dal nome, per la creazione di Guglielmo da Baskerville) abbia avuto modo di contraddirlo, sostenendo che si tratti più propriamente di abduzione, o apagoge secondo la Logica aristotelica, ossia di un tipo di sillogismo in cui la premessa maggiore è certa e quella minore soltanto probabile.
L’aspetto che maggiormente cattura la simpatia del lettore è sicuramente questa sua acutezza sovrumana, ma sono altresì tutti i particolari di contorno alla sua caratteristica principale a concorrere efficacemente all’innalzamento monumentale di Holmes: la calabash in schiuma di mare, il cappello da cacciatore di cervi calato sugli occhi, la mantellina a scacchi, la cocaina iniettata in vena.
La forza di un personaggio traspare dalla sua capacità di sopravvivere al proprio creatore: Holmes non appartiene più a Doyle e tanto meno a un’esistenza puramente cartacea. È stato presto ripreso da centinaia di emuli. Tuttora vive nuove scorribande in telefilm che ne attualizzano le gesta, quali Sherlock ed Elementary, o in film che cercano di reinterpretarne la figura secondo una sensibilità contemporanea, pur lasciando i personaggi nella temperie storica dei primi romanzi, come nei film di Guy Ritchie.
E chi, passando da Londra, non è andato a visitare il suo studio al 221/b di Baker Street, dove ogni dettaglio fittizio fornito dal cosiddetto “canone sherlockiano” è stato riprodotto e musealizzato come si trattasse di una persona effettivamente esistita?
E dire che Sir Arthur, dopo alcuni romanzi e molti racconti a lui dedicati, cercò di disfarsi di Holmes, che viveva ormai come una gabbia creativa, facendolo volare giù per delle cascate, avvinto in una lotta all’ultimo sangue col suo nemico giurato, il Professor Moriarty, altrimenti definito “il Napoleone del crimine.”
Subissato da migliaia di lettere di protesta da parte dei fan più accaniti fu poi costretto a ritornare sui propri passi, far resuscitare Holmes e fingere che fosse stata tutta una messinscena…
Ora concentriamoci proprio su Sir Arthur Conan Doyle, creato baronetto per meriti letterari nel 1903 (non però in quanto autore del ciclo sherlockiano, bensì grazie a un resoconto di guerra).
Era un medico militare (come Watson) di origini scozzesi.
Man mano che si procede nella lettura delle avventure di Sherlock Holmes, si resta sempre più meravigliati dalle straordinarie capacità intellettive del personaggio. A molti lettori verrà da domandarsi quanto mai dovesse essere intelligente l’uomo che aveva inventato un individuo di tale intelligenza (forse anche spinti da quella voglia, che sorge naturalmente nel lettore che si trovi di fronte a un personaggio ricco di una particolare attrattiva, che costui davvero esista, in carne e ossa, e non sia aridamente relegato a un’esistenza farlocca e cartacea).
Ma funziona davvero così? Il creatore di un personaggio geniale è lui stesso geniale? Anche nella sua vita di tutti i giorni?
Arthur Conan Doyle possedeva facoltà intellettive e deduttive paragonabili a quelle di Holmes?
I cenni biografici paiono negarlo recisamente…
Infatti la caratteristica preminente di Doyle, al di fuori della sua invenzione con pipa e mantellina a quadretti, è la creduloneria più sprovveduta. Egli, tutt’al contrario di quel campione di razionalismo che è Sherlock Holmes (figlio dell’epoca positivista entro cui fu forgiato), abboccava a qualunque ciarlatano sostenesse di poter conferire coi trapassati, di saper muovere tavolini con la sola forza del pensiero o di poter vomitare ectoplasmi. Era insomma il più grande fautore dello spiritismo di tutto il Regno Unito, colonie comprese.
Famoso resta l’incontro che ebbe col prestigiatore Henry Houdini. Entrambi interessati all’occultismo, vi si erano avvicinati per ragioni consimili: Houdini per riuscire a contattare la madre deceduta, Doyle per contattare il figlio e il fratello morti durante la Grande Guerra. Solo che, mentre il primo, dopo qualche esperienza fraudolenta coi medium, divenne il loro peggior detrattore, il secondo mai dubitò della bontà dei molti sensitivi con cui ebbe a che fare. Tanto che l’imbattuto asso dell’escapologia, che si presentava inizialmente come un accanito seguace di Doyle, finì per farsi beffe di lui, come di un vecchio boccalone disposto a versare dei capitali ai primi cialtroni, giusto capaci di mettere in piedi un paio di trucchi, in cui si imbattesse.
A dimostrazione di quanto fosse offuscato l’intelletto di Doyle rispetto a quello di Holmes basti ricordare il colossale granchio che lo scrittore prese nel campo della scienza occulta: le fotografie delle fate di Cottingley.
Nel 1917 due cuginette della contea di Bradford scattarono cinque istantanee in cui le si vedeva immortalate in compagnia di alcune piccole creature fatate.

La serie di scatti fece presto il giro del mondo. Ma anche se le immagini riuscirono a creare un certo scalpore, in pochi potevano davvero credere che in esse si potessero ammirare fatine realmente esistenti. Tra questi pochi, manco a dirlo, c’era il povero Conan Doyle, il quale si impegnò in una campagna pubblicitaria senza confini per rimarcare la veridicità delle foto.
Negli anni ’80 poi, ormai anziane, le due cugine rivelarono il trucco: molto semplicemente avevano ritagliato delle figurine di fate da alcuni libri di fiabe e le avevano posate sul prato di casa, accanto a loro, simulando, a favore di obiettivo, un qualche tipo di interazione.
Eppure Doyle se l’era bevuta con tutto il bicchiere. A dimostrazione di come, per qualche strano incantesimo, questo sì davvero feerico, proprio del talento artistico, non di rado possano uscire prodotti pieni di genio puro da una mente per altri versi tutt’altro che brillante…